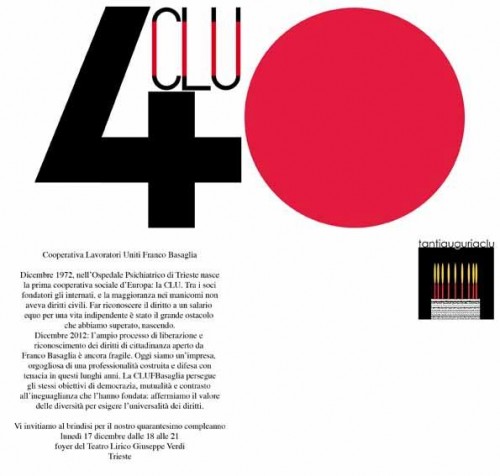La partecipazione da testimone quasi inconsapevole alla nascita della cooperativa, 40 anni fa, ha inciso più di ogni altra cosa sulla mia formazione. Ha strutturato la mia visione sulla questione del lavoro, dei laboratori, del diritto, delle identità, delle guarigioni.
E’ il 1972, Trieste, ospedale psichiatrico, 1200 internati, ergoterapia. Gli internati lavorano nell’ospedale perché fa bene, è terapeutico. Altri avevano detto che il lavoro rende liberi. Gli internati lavorano ma non vengono pagati. E’ la terapia appunto. In verità ogni fine settimana vengono compensati con una gassosa, una spuma, un pacchetto di sigarette oppure con una targhetta di rame che serve a comprare nel piccolo spaccio, accessibile solo agli internati lavoratori, una gassosa, una spuma, un pacchetto di sigarette. Soltanto alfa e nazionali.[1]
Si aprono le porte, si fanno assemblee, si discute di ogni cosa, tutti possono uscire dai reparti. E tutti escono nel parco e anche in città. I lavoratori, quelli dell’ergoterapia, vedono ridotto il loro unico vero compenso. Il reale vantaggio di essere lavoratore, infatti, non è ricevere a fine settimana il conio di rame ma è soprattutto la possibilità quotidiana di uscire dal reparto. Per sottrarsi al tempo servo dell’istituzione edifendersi dal rischio terribile di vivere una vita senza tempo. Lavare pentole e verdure in cucina, stirare e piegare quantità gigantesche di lenzuola in lavanderia, spalare la neve o tagliare l’erba nel parco sono azioni che scandiscono e definiscono il tempo e permettono di attraversare luoghi diversi dal camerone del reparto. I lavoratori hanno il privilegio, soprattutto l’illusione, di vivere un tempo proprio, quanto meno di non essere annientati dall’assenza del tempo che è la conseguenza più tragica della malattia e dell’istituzione. In questo senso i lavoratori sono diversi e privilegiati.
Adesso che si sono aperte le porte tutti escono, tutti ricevono una sorta di piccola paga settimanale e possono andare al bar.
Adesso che è possibile parlare i lavoratori, quelli dell’ergoterapia, cominciano a dire del loro lavoro e delle loro speranze nell’ assemblea generale del giovedì.
In quelle assemblee nasce il primo progettodi associazione e di costituzione di una cooperativa: fare in modo che gli internati che lavorano possano essere retribuiti, avere un contratto. Un progetto del genere per quei tempi è decisamente utopico, quanto meno bizzarro. Siamo nel 1972, la legge sulle cooperative sociali arriverà soltanto nel 1991.
Naturalmente il percorso è tutto in salita
Gli operatori, e gli infermieri soprattutto, si alleano con gli internati. Gli infermierivedono nel riconoscimento del lavoro degli aspiranti cooperativisti una valorizzazione del loro lavoro. Non saranno più i pulitori o gli inservienti, finalmente verranno riconosciuti nel loro ruolo sanitario e terapeutico. Si costruisce un’alleanza per un obiettivo comune, si generano contrasti con l’amministrazione provinciale. Il presidente della Provincia Michele Zanetti si batte per rendere possibile la nascita della cooperativa. L’assemblea e parte della giunta non colgono la lungimiranza delle scelte del presidente. Si arriva così a uno sciopero ed è un’immagine questa assolutamente straordinaria che io, solo oggi, posso comprendere nella sua profondità e nelle sue conseguenze per la vita e i destini di tante persone.
Sciopero! Quelli dell’ergoterapia incrociano le braccia. Utilizzano la fragile ed illusoria identità di lavoratori e rivendicano il diritto di uscire da quella condizione ingannevole, di avere un lavoro vero, di essere cittadini. Con lo sciopero la contraddizione dell’ergoterapia, della terapia e della riabilitazione in manicomio esplode. Una circostanza particolare, un’alleanza, una consapevolezza appena raggiunta restituisce per un giorno la possibilità di essere in scena, quasi come veri cittadini.
Per un giorno l’ospedale si ferma. I piatti non vengono lavati, le cucine non preparano i pasti, i letti non vengono rifatti, i corridoi restano sporchi. Il processo di riconoscimento della cooperativaaccelera e si arriva alla firma del contratto: l’amministrazione provinciale affida le pulizie alla neonata cooperativa. La firma di un regolare contratto sindacale guarisce in un solo momento 60 persone. E’ la prima ed unica volta che mi è accaduto di assistere a un processo di guarigione collettiva.
Fu gioia e festa grande in tutti i reparti. In quel momento si svelava l’inganno: la sofferenza, la violenza subita, il dolore era diventato qualcosa d’altro all’interno della diagnosi, della malattia, del manicomio, sottraendo alle persone ogni cosa: diritto e contrattualità, sentimenti e affetti, nome e cognome. Il manicomio e la malattia avevano prodotto soltanto oggetti, povere cose da collocare in un lontano altrove.
La firma del contratto rimetteva tutto in gioco. Gli internati, finalmente persone, si riappropriavano della possibilità di scommettere la loro vita, di giocarla dentro le relazioni reali, nel mondo ruvido delle contraddizioni.
Da qui è stato possibile cominciare a guardare con occhio diverso la persona con disturbo mentale e noi tutti, gli psichiatri prima di tutto e, con loro, tutti gli operatori della salute mentale, siamo stati costretti a interrogarci sul nostro ruolo, a relativizzare, a considerare le persone in relazione con la malattia e non ad essa sottoposte, a rinunciare alle sicurezze del nostro potere disciplinare e istituzionale.
Come avrei potuto io scorgere, indovinare, riconoscere il lavoratore, la madre, il marinaio, lo studente; dare spessore e valore a quella particolare storia di quella singolare persona restando all’interno di una condizione che era la mia di psichiatra e che era la sua di malato mentale?
Era un passaggio cruciale e inevitabile quello che dovevamo fare e che instancabilmente oggi dobbiamo riproporre. Non è stato e non è affatto semplice. Avevamo la necessità di riconoscerle queste persone, valorizzare la loro potenzialità, la loro creatività, narrare la loro storia, sostenerle nel percorso durissimo e rischioso della riemersione. Questo significò mettere tra parentesi la diagnosi, la clinica, la malattia che ormai aveva prodotto solo macerie, relitti, rottami. Da qui tutto è stato di una chiarezza abbagliante, e affascinante per me: la persona, non la malattia, sarebbe stato il futuro e il significato del nostro lavoro.
[1]In “non ho l’arma che uccide il leone. Trent’anni dopo