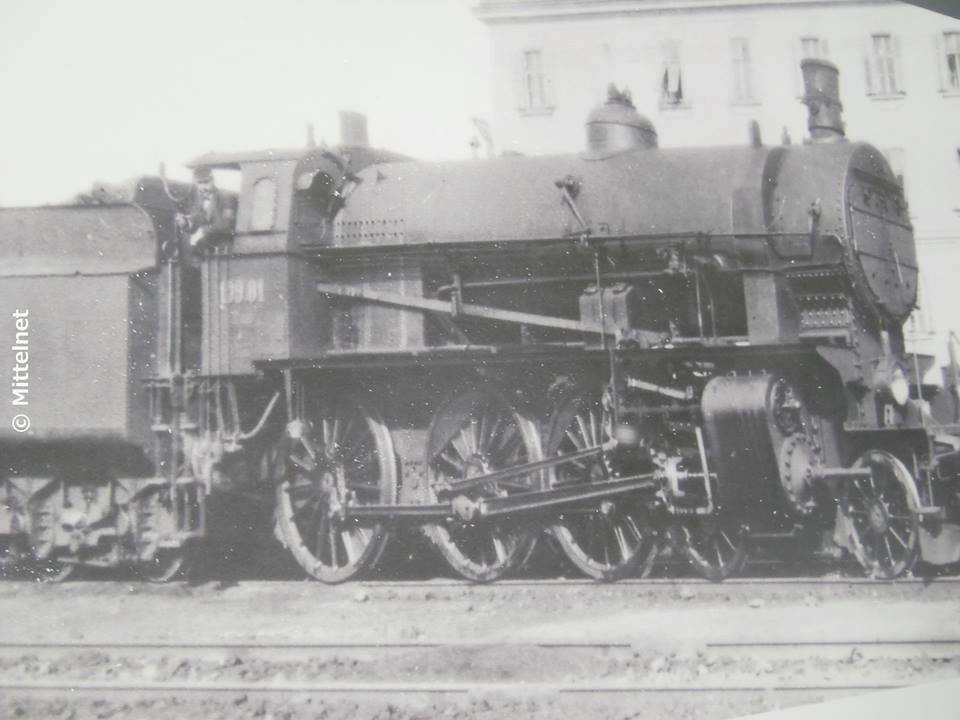di Salvatore Marzolo
28 febbraio 2022
“Vuoi lasciare questa barca a vela per una chiatta che puzza di pasta e fagioli”
In questa breve riflessione a partire dal saggio “Fare la 180. Vent’anni di riforma psichiatrica a Roma” cercherò di utilizzare le pagine scritte da Losavio come utensili per maneggiare e manipolare il materiale vivo e presente di cui quotidianamente faccio esperienza da specializzando in Psichiatria al IV anno.
Cercherò di affrontare 4 passaggi che riassumo di seguito:
1.Una nostalgia per il futuro: quando tornare indietro è un andare avanti
2.Lo psichiatra, il paziente dimenticato: all-in sulla formazione
- Tra reti nazionali e gazzette locali: ripopolare le piazze
4.Giocare con i monumenti: cantieri sempre aperti
Quando tornare indietro è un andare avanti
Non si può che partire dall’insoddisfazione, dalla mancanza. Leggere il saggio di Losavio, ripercorrere emotivamente quegli anni di fermento dal basso e di trasformazione pratica delle strutture esistenti del “si è sempre fatto così”, d’invenzione faticosa e artigianale di pieni dai vuoti, comporta un certo tipo di nostalgia, una strana nostalgia di un luogo in cui, apparentemente, non si è mai stati.
Dico apparentemente, perché levando lo sguardo dalle pagine che scorrono veloci sotto le dita, e fissandolo per un attimo intorno, i paesaggi ancora oggi non sono poi così dissimili, a guardarli bene, da quelli descritti nel saggio. La nostalgia diventa quindi qualcosa di diverso, una curiosità e un entusiasmo convocati a raccolta dal futuro, da un viaggio ancora possibile. Quando si accetta la sfida del viaggio, è difficile che non ci si ritrovi a pensare con Losavio che “avevo l’impressione di portare l’acqua con un secchio bucato”. Il sistema economico-politico neoliberale, la cultura del trionfo assoluto del privato, il modello biomedico di gestione della malattia e della salute, informano molecolarmente noi giovani specializzandi e specialisti.
Avvenuta ormai la “mutazione antropologica” ventilata da Pasolini, siamo uomini e quindi professionisti diversi da quelli descritti nel saggio e che hanno “fatto la 180”.
Chi siamo? Che fare allora?
“Tu la fai facile Losavio. Ma tu lo sai quanto è difficile per me entrare fuori?” È la domanda che nel libro, Nino, un ricoverato, gli rivolge. Oggi mi pare che questa sia una questione che un operatore della salute mentale di qualsiasi provincia italiana può tenersi dentro e per vergogna o imbarazzo non esprimerla.
Fuori dalla clinica universitaria, fuori dallo studio privato, fuori dalla struttura riabilitativa convenzionata, fuori dal manicomio, che cosa c’è? Non è facile infatti uscire dalla caverna buia, in pieno giorno. Gli occhi hanno bisogno di tempo per adattarsi e non farsi bruciare dal sole. Ancora più difficile è uscire con decisione da pratiche descritte come aderenti a standard internazionali, a linee guida validate da ricerche oggettive, scientifiche in doppio cieco, randomizzate, e promosse da relatori con ottimi curricula, in cui tutto appare chiaro ed evidente, senza ombre, senza alcuna contraddizione possibile. “Non è poi il manicomio!”
Eppure quella sensazione rimane, quella sensazione che qualcosa non torni. Che fine ha fatto il paziente? La sua voce? La sua crisi, la nostra?
Lo psichiatra, il paziente dimenticato: all-in sulla formazione
A volte penso che non ci siamo presi abbastanza tempo e pazienza per curare le ferite sanguinanti del “signore della follia” disarmato e spodestato dal suo feudo. Che cosa resta della psichiatria fuori dal manicomio? E soprattutto che cosa resta dell’operatore, anzi, ancora di più, chi è l’operatore della salute mentale fuori dalla struttura ospedaliera? In una delle conferenze brasiliane a Belo Horizonte, Franco Basaglia dice: “Prevenire la malattia vuol dire operare per mantenere la salute. Ma noi medici, che siamo istruiti nelle università per curare le malattie, non sappiamo cos’è la salute, sappiamo solo cos’è la malattia. Se vogliamo cambiare veramente le cose dobbiamo incominciare a imparare all’università cosa vuol dire il sociale nella medicina, perché l’uomo non è fatto di corpo – è fatto anche di corpo – ma è fatto di sociale, e nel momento in cui il sociale entra nella medicina il medico non capisce più niente, perché è abituato a pensare che il suo malato sia un corpo malato, un tumore, un fegato malato, una testa malata. Non gli viene mai in mente che questa malattia, che questa condizione è la vita stessa delle persone”.
E ancora oggi, forse, bisognerebbe chiedersi, che alternative concrete abbiamo fuori dal centro di salute mentale, dal servizio di diagnosi e cura, dalla struttura, dalla clinica universitaria? Che sapere, che pratiche proporre, seguire? È difficile orientarsi al buio senza una torcia propria, o quella di un compagno, ed è quasi impossibile farlo nel mondo della salute mentale, senza uno spazio di confronto, di pratica ed esperienza condivisa, senza una visione politica del proprio ruolo e una posizione etica che permetta di accorgersi che ciò che accade in un CSM di Vibo Valentia riguarda ciò che sta accadendo in un tribunale di Trieste e in una scuola elementare di Biella, che ciò che accade ci riguarda.
Tra reti nazionali e gazzette locali: ripopolare le piazze
Accettare la sfida del viaggio, oggi, significa per forza ripartire dalle foto di famiglia, dall’incontro corpo a corpo con i compagni di viaggio. Riscoprire i volti di chi queste domande le ha già frequentate, i testi-traccia che ha lasciato per strada, le esperienze-orme disseminate ancora calde in tutto il territorio nazionale. Significa mettersi in ascolto di chi ha provato a reggere, insieme alla propria comunità, all’urto dello straripamento della “malattia mentale” dai luoghi in cui era relegata, e di tenere ferma la posizione davanti all’esplosione della follia nel territorio, nelle famiglie, nelle scuole, nei luoghi di lavoro. Mettersi in ascolto di chi ha provato, di chi ha fallito, di chi è rimasto. Non è per niente facile oggi portare nello zaino dell’operatore della salute mentale insieme al fonendoscopio e al DSM (il manuale!), anche una cartina del proprio quartiere e la gazzetta locale; imparare a offrire un caffè piuttosto che una fiala di Talofen, un abbraccio al posto di lacci di contenzione. Non è per niente facile pensare la complessità, il groviglio biopsicosociale come ordito di ogni cosa che accade. È faticoso, e serve imparare costantemente, serve formarsi per reggere l’urto con il Reale, la transizione costante di paradigma, la sospensione dell’ovvio, perché la vita non conclude. Serve andare all-in sulla formazione. La rabbia e la sensazione di impotenza che paralizzano quando non vengono riconosciute, è necessario che oggi si accompagnino mano nella mano alla fiducia e all’imprevedibilità della scommessa di chi vuole di nuovo tentare l’orizzonte e arrivare a dire con Losavio: “mi hanno fatto capire che era possibile cambiare ciò che sembrava immutabile sedimentatosi in centinaia di anni nella violenza, nella negazione dei diritti, nella cronicizzazione istituzionale, nella costruzione di un corpo disciplinare che sosteneva e alimentava l’impossibilità di fare altrimenti”.
Giocare con i monumenti: cantieri e altre soluzioni collettive
La parola che apre l’intenso saggio di Losavio è proprio “la sfida”. Poco dopo altre parole impegnative e ormai desuete vengono invocate, quali “scommessa”, “voglia di mettersi in gioco”, “utopia”, “la promessa era un impegno, continuavamo con ostinazione, tenacia e fatica, ma non senza entusiasmo, nel nostro lavoro. Studiando anche: “..bisognava inventare il centro di salute mentale”.
Ma Losavio ci ricorda come le grandi rivoluzioni partono sempre con un gesto semplice e fatto alla prima persona plurale, come quando “comprammo delle piantine e le regalammo ai condomini” del condominio del nuovo gruppo-appartamento. Tempo fa in una riunione a Gorizia degli operatori del CSM con la Cooperativa Sociale NCO (“Nuova Cucina Organizzata”), Peppe Pagano ricordando come avevano incominciato le loro azioni di riutilizzo dei beni confiscati alla camorra disse “Noi eravamo giovani, e avevamo molta paura. Per questo da subito abbiamo iniziato a metterci in rete”. Dal saggio di Losavio ritorna chiaro come per l’incursione nel buio sia di primaria importanza l’ottimismo della prassi unita alla spinta a organizzare continui scambi reciproci di confronto e visita tra gli operatori dei e nei servizi. I vari attori del cambiamento sia a livello nazionale che a livello locale hanno bisogno di riconoscersi dalle ferite, di confrontarsi sulle varie invenzioni creative con le quali ognuno di loro prova a tenere aperte le contraddizioni e a farne qualcosa di utile nel processo di cura e deistituzionalizzazione. Serve infatti una rete viva, bollente di persone che si muovano insieme anche se con scarpe e su strade diverse, che si incontrino, che si ascoltino e che insieme si assumano la responsabilità e l’impegno di essere all’altezza delle crepe che continuamente e fortunatamente si aprono lungo il sentiero. Durante la formazione e il successivo lavoro nei servizi, mancano generalmente questi momenti di incontro tra territori geografici e di competenza. Lo psichiatra fa lo psichiatra, il tecnico della riabilitazione fa il tecnico di riabilitazione. Quello che succede a Ferrara è completamente diverso da quello che succede a Napoli. Ma la follia non legge i manuali di geopolitica, esonda, rilancia, sconfina. Al particolarismo del proprio giardino, oggi serve articolare una visione ampia di sfida pratica comune.
Come ricorda la Giannichedda in postfazione manca inoltre, a oggi “una riflessione su quel periodo”.
Come ha già fatto in maniera pregevole per esempio Daniele Pulino nel suo saggio raccolto nella collana 180 “Prima della Legge 180. Psichiatri, amministratori e politica “, serve oggi più che mai ripensare e riscrivere un lessico familiare tra gli operatori della salute mentale, gli utenti e le famiglie, coltivare e innaffiare un albero genealogico comune, pensare a una certa comunità che sappia riconsiderare gli ultimi, gli esclusi, i matti, che sappia riconsiderarne lo scandalo gravido.
Serve anche riscoprire l’orgoglio di ritrovarsi all’interno di una storia di una disciplina che solo pochi anni fa ha trainato i movimenti di riforme civili e di trasformazioni dal basso nella società italiana, e non solo. Di avere scelto una pratica di cura che può illuminare la strada, insieme con le altre specializzazioni mediche e con le comunità, per una relazione terapeutica che non escluda, che consideri e riconsideri la complessità dei determinanti di malattia quanto di salute, che sappia ancora inchinarsi clinicamente di fronte alla sofferenza dell’uomo come di fronte ad una questione che riguarda ciascuno. E tutto ciò senza dimenticare criticamente le proprie “origini infami”. Serve oggi ritrovare una comunità che non lascia soli, che protegga senza giudicare, che sproni e promuova ad andare avanti, servono pranzi culturali comuni e spazi pubblici di incontro/scontro, servono ring e terzi tempi. Oggi l’impegno è smontare e rimontare criticamente gli anni della riforma, per coglierne giustapposizioni inedite che permettano lo sprigionarsi di nuova energia differenziale e pertanto di nuovo movimento e movimenti. Oggi l’impegno è rompere le scatole ermetiche a tenuta stagna, vedere nei muri percorsi, nell’ovvio una possibilità, aprire cantieri vicino ai monumenti. Il presente come ricorda Di Vittorio, ripensando a Benjamin, dovrebbe essere una miccia che accende i materiali esplosivi che sono contenuti nel passato. Nel nostro piccolo è quello che stiamo provando a fare un collettivo di operatori della salute mentale (“Ponti di Vista”) con il quale da ormai un anno organizziamo online degli incontri con clinici e ricercatori italiani che possano raccontarsi e aprire spiragli di possibile nel solito. È un’esperienza impegnativa e responsabilizzante, attraversata da crisi e contrasti, ma mossa da una spinta comune a non abituarsi e a non rassegnarsi all’abbrutimento e al nichilismo raccontato e vissuto nei servizi, a fare gruppo fiducioso dove prima c’era solitudine disperata, a fare di un incontro un grimaldello che possa disarticolare l’indifferenza fatalistica che spesso contagia e ci contagia.
Grazie a questi incontri promossi dalla Fondazione Basaglia e all’interno della visione promossa dal Forum di Salute Mentale, viene più semplice riaccendere la nostra pulsione di sapere per problematizzare il nostro presente, continuare a interrogare i feticci, non smettere di dialogare con il passato in un tavolo sismico di lavoro comune. La 180 esige infatti di rimanere un cantiere sempre aperto, perché bisognerà sempre “fare la 180”, auspicando che ai racconti di Roma facciano seguito racconti di altre città, in Italia come intorno al mondo.
“Li si stava trasformando un pezzo di mondo. Il lavoro che si faceva non era semplicemente quello di chiudere l’OP, ma si tentava di cambiare radicalmente il modo di porsi nei confronti della sofferenza, di decostruire gli stereotipi nei confronti della follia, di trasformare la cultura”.