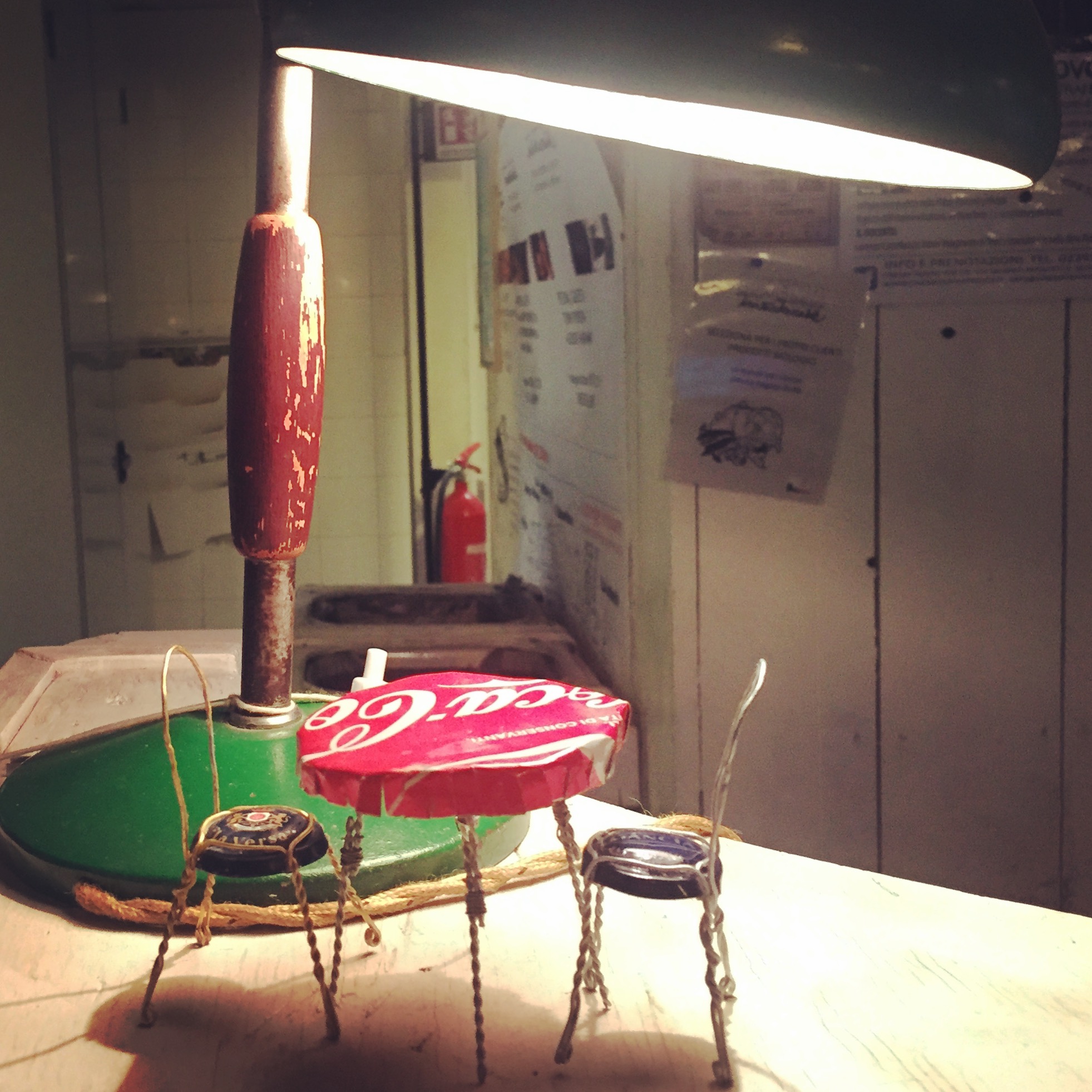
di Peppe Dell’Acqua e Silvia D’Autilia
[pubblicato su Charta Sporca http://www.chartasporca.it/in-punta-di-piedi-osservazioni-sul-suicidio-e-sulleffetto-werther/]
Si racconta che in un’isola dell’antica Grecia la figlia del re, colpita nell’amore, si sia data la morte con le proprie mani. Pare anche che tutti i sudditi abbiano partecipato, dolenti, al lutto e alla disperazione del re e della regina. Le cerimonie funebri si sarebbero protratte addirittura per un’intera settimana, durante la quale il corpo della fanciulla sarebbe rimasto esposto davanti al palazzo reale tra i fiori più belli e gli incensi profumati, mentre sciami di cantori e danzatori – fatti giungere da tutte le isole vicine – ne narravano le gesta, la vita, le sublimi qualità e la bellezza. Nonostante il cordoglio, i canti e le cerimonie toccassero ogni angolo del paese, e nonostante tutti si stringessero intorno agli inconsolabili genitori, il re e la regina faticavano a trovare una ragione.
Quella luttuosa settimana, così ricca di passione, di sentimenti e di partecipazione, avrebbe però prodotto, di lì a poco, un effetto inaspettato: un’altra giovane donna nei giorni successivi si dette la morte. Di nuovo allora l’isola si fermò, e di nuovo furono indette accorate e dolenti cerimonie funebri. Non solo, poco tempo dopo, nuovamente, una terza ragazza innamorata mise fine alla sua vita. Il re allora, benché ancora sconvolto e perso nel suo dolore, sembrò riuscire a cogliere il senso di quanto stava accadendo, e ordinò che tutte le cerimonie funebri pubbliche fossero bandite e che il cordoglio per quelle morti, così amare e infelici, venisse celebrato privatamente dai clan familiari.
Michele, un giovane trentenne di Udine, il 31 gennaio scorso si è dato la morte lasciando un lungo scritto in cui diceva della sua fatica di vivere. Leggiamo ora sul Fatto Quotidiano che viene messa in dubbio la veridicità di quello scritto. Il direttore del Messaggero Veneto confessa di non aver controllato la fonte e di non sapere con certezza se siano stati i genitori a inviarla in redazione. Sembrerebbe che una giovane amica si sia inserita nella vicenda. In ogni caso, che i genitori di Michele abbiano o meno inviato di persona la lettera alla redazione è cosa che qui interessa poco; quel che ci interessa sono invece le conseguenze prodotte della divulgazione della lettera d’addio di Michele.
Dopo il clamore mediatico delle scorse settimane, con cautela e con la consapevolezza del limite, cerchiamo dunque di avvicinarci alle cose umanissime che accadono e che pretendono soltanto la messa in gioco della nostra singolare fragilità: mordersi la lingua, fare un passo indietro.
Le spiegazioni sentenziose che sono seguite – pubblicando, speculando e strumentalizzando – alla lettera di Michele sono state tali e tante da sommergere letteralmente la sue stessa sofferente e fragile esistenza. Così come la disperata presenza sulla scena dei genitori, a sua volta, è stata oscurata dalla volontà di rendere esemplare quella morte.
Sopravvivere al proprio figlio è impensabile e nessuno di noi – a differenza dei nostri nonni, quando le morti dei bambini e dei giovani erano frequenti e facevano parte di quella cultura – è capace oggi di figurarsi un’irruzione così violenta nella propria vita. Per chi vive questa esperienza, si dice sia il dolore più grande. Lo strazio per il figlio che abbandona volontariamente la vita è semplicemente indicibile. I modi che un genitore riesce a usare per tentare di arginare la valanga di disperazione che lo assale non possono che essere comprensibili; non la decisione dei giornali di pubblicare quella lettera e non di certo il corteo di commentatori che hanno fatto della morte di Michele un argomento di polemica politica: dalla copertina di Panorama che titola i suoi servizi “generazione Michele”, fino ai giovani del movimento di Bologna che sui muri dei supermercati Coop hanno giurato vendetta per quella morte.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha promosso numerose campagne per far fronte al fenomeno del suicidio, che in alcuni paesi assume dimensioni allarmanti. Ogni anno si contano nel mondo un milione di suicidi. Si tratta di un suicidio ogni 20 secondi. In Italia il tasso medio oscilla tra i 5 e i 7 per centomila e per anno. In Europa il tasso medio è di circa tre volte superiore a quello del nostro paese.
La comunicazione del suicidio, ovvero le parole, le forme, il tono che radio, televisioni e giornali usano, vengono indicati come momenti cruciali, punti strategici di tutti i programmi di prevenzione. Le numerose linee guida che si sono susseguite nel corso degli ultimi vent’anni tentano di formulare una carta per un’etica della comunicazione.
Nel nostro paese, dal 2010, la cosiddetta “Carta di Trieste” è il codice etico-deontologico per operatori dell’informazione che trattano notizie concernenti questioni legate alla salute mentale e al suicidio. Il giornalista dovrebbe interrogarsi sulla proprietà e la misura delle parole che usa con la finalità di non colpire le tante persone che quelle fragilità stanno vivendo. Così i titoli, le immagini, le spiegazioni dei fatti non dovrebbero mai essere tanto dettagliati da costituire una sorta di indicazione o facilitazione per chi vive momenti di incertezza riguardo alla propria vita. Soprattutto si raccomanda di fuggire dalle facili spiegazioni riduttive causa-effetto, di evitare narrazioni eroiche che enfatizzino oltremisura il gesto. Il rischio d’indurre comportamenti emulativi nelle persone più fragili è il cuore delle raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità.
Il clamore mediatico intorno al gesto di Michele fa ripensare proprio alla saggezza di quell’antico re, ai Dolori del giovane Werther e alla straordinaria presa sugli animi sensibili che in quel tempo ebbe l’idea romantica della morte: un’epidemia di suicidio, un’induzione al gesto. Nel romanzo di Goethe il protagonista si suicida infatti perché innamorato della ragazza che sposerà il suo migliore amico. Alla pubblicazione del romanzo seguirono molti suicidi di giovani che leggevano il testo.
L’effetto si ripropose anche nei paesi nei quali vennero pubblicate traduzioni del libro. L’espressione “effetto Werther” si riferisce, non a caso, al fenomeno per cui la notizia di un suicidio, pubblicata dai mezzi di comunicazione di massa, provoca nella società una catena di altri suicidi.
I meccanismi mentali sono in crisi, la nostra capacità di accogliere l’inatteso ci toglie il respiro: un chiarimento deve giungere in soccorso a placare un conflitto intimo e metterci un po’ più al sicuro. Anche se, a ben vedere, non è necessariamente di una spiegazione che abbiamo bisogno. L’osservazione empirica può servire ad avvicinarci a una definizione del fenomeno: la decifrazione di eventi complessi come il gesto di Michele non sta in una statistica, in una media o in una lettera, e men che meno in un talk show televisivo. Un evento umano è e deve restare umano.
Interrogarsi sulle cause di un gesto così drammatico e terminale non è come procedere a un esame autoptico, in cui si cerca di trovare la lesione o l’organo malato. Solo la narrazione e la biografia possono permetterci di avvertire gli abissi del dolore individuale, aiutandoci così a entrare in un campo che resta comunque difficilmente penetrabile. La biografia non è biologia.
Tutti noi incontriamo la vita e con essa gli eventi che la segnano, la valorizzano e la deformano, che la contrastano, la facilitano, e che, comunque sia, la contraddistinguono. In termini storici, sociologici, politico-economici, ogni soggetto non può essere tale se non a condizione di scontrarsi con le realtà e le micro realtà del suo tempo. Far discendere da quelle circostanze, deterministicamente e razionalmente, un fatto così drammatico e tanti altri che sconcertano per la smisurata passione che contengono, è una debolezza culturale, una pace apparente della coscienza, che ci sottrae a una riflessione che pretenderebbe silenzio, vicinanza e intimità. Chi di noi almeno una volta non ha pensato di voler scomparire? Di togliersi la vita? Chi di noi per esempio non ha mai pensato e immaginato il suo funerale, anche solo in una dimensione onirica?
A partire dalla seconda metà dell’Ottocento un’attenzione particolare viene rivolta al suicidio, il quale diviene oggetto di osservazione e di concettualizzazione attraversando diversi ordini di discorso. Le nascenti scienze umane, dalla sociologia alla psicologia, dall’antropologia alla psichiatria, s’interrogano sulla consistenza e la natura di questi fatti.
Émile Durkheim, per esempio, nel testo Il suicidio. Studio di sociologia del 1897, analizzava già l’insieme oggettivo dei fattori socio-antropologici che possono contribuire alla produzione di questo fenomeno. Assertore della tesi che è sempre la società a creare gli individui e non viceversa, Durkheim considerava fattori di rischio e fattori di protezione (legami forti, appartenenza religiosa, cicli economici, assetti politici e così via), propendendo per una spiegazione e una classificazione che ha fornito strumenti di lettura fondamentali, e ancora attuali, per una sociologia del suicidio.
Si realizza così storicamente una visione sempre più scientifica e precisa, una rappresentazione statistica e schematica, che però purtroppo finisce per perdere di vista il soggetto. Da questo momento in poi infatti le conoscenze che ci permettono d’inquadrare il fenomeno in tutto il suo spessore, nella sua estensione, in tutti i paesi e in tutte le culture, sembrano dire tutto quello che si deve sapere. L’effetto indesiderato è la riduzione di queste statistiche a verità oggettive, a cui viene demandato il diritto (e il dovere) di spiegare ogni cosa, compresa la dimensione dell’hic et nunc e dell’individuale.
Fare di un istante complesso della vita privata di una persona – quale è il momento della scelta suicida – l’oggetto di una rappresentazione scientifica non può che avere come conseguenza la svalutazione del mondo del soggetto a vantaggio del mondo oggettivo. Una coazione a spiegare che oscura il desiderio di comprendere. Non dobbiamo dimenticare infatti che l’ultima parola spetta sempre ai vissuti della persona, di fronte ai quali le certezze e le descrizioni oggettive non possono che indietreggiare, mettersi tra parentesi.
Quando i media parlano di suicidio fanno appello ad andamenti, statistiche e dati certi. Il tono è sempre di allarme ed è come se si scoprisse sempre per la prima volta che quel fenomeno esiste. Non solo, a questa tendenza si associa anche quella di chiamare in causa le culture e i comportamenti del momento: i giovani e le droghe, gli anziani e la solitudine, la crisi economica e la disoccupazione. Salvo poi scoprire, all’indomani e a un’analisi più attenta, l’infondatezza di quelle conclusioni e di quelle deduzioni. Basterebbe qui ricordare l’allarmata denuncia di suicidi degli imprenditori nei primi mesi della recente crisi economica!
Come si può, passando drasticamente dal singolare al generale, oggettivare la fine di una relazione d’amore, di una frustrazione professionale, di un fallimento, rendendoli la causa specifica di un gesto tanto intimo e segreto? La morte di Michele è la morte di Michele. Di nessun altro. Le circostanze che vengono chiamate in causa, dalla precarietà al futuro che non c’è più, dall’assenza di piacere ed entusiasmo alle delusioni amorose, raggiungono livelli di sconvolgente profondità in quella singolare storia e in quel singolare momento di vita di una persona unica.
L’uso di quelle parole a sostegno di critiche o ribellioni più o meno comprensibili, ma sicuramente non conciliabili con la drammaticità della scelta della quale stiamo parlando, non può che essere definito strumentale. La morte di un giovane c’interroga sempre, e non può che pretendere la presenza della nostra incertezza e della nostra fragilità.


