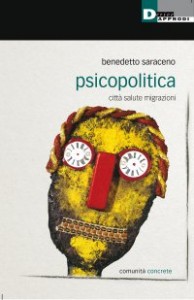 Di Benedetto Saraceno
Di Benedetto Saraceno
Undici brevi riflessioni morali su questioni fondamentali ma anche attuali: la città e le sofferenze individuali e collettive che la attraversano, la salute e i suoi determinanti sociali, i fenomeni migratori e le contraddizioni che portano, la insofferenza per un presente rancoroso e la speranza in un futuro più umano.
Il mood del libro è reso a mio parere da due citazioni. Una, dal Diario di Anna Frank: «È un gran miracolo che io non abbia rinunciato a tutte le mie speranze perché esse sembrano assurde e inattuabili. Le conservo ancora, nonostante tutto, perché continuo a credere nell’intima bontà dell’uomo.» L’altra, da una conferenza del filosofo inglese Simon Critchley: «La lezione della tolleranza, dell’accoglienza, del dubbio: cosa c’è di più importante in questi tempi di fondamentalismo, fascismo strisciante, dottrine economiche, politiche e pseudoreligiose fondate sulla presunzione e sull’odio?».
Innanzitutto il tema della città e della sofferenza urbana: la città nega agli individui la loro dimensione collettiva di sofferenza (non fornisce risposte sociali collettive) ma invece li costringe in tribù identitarie. Paradossalmente la città risponde solo individualmente (burocrazia, solitudine, povertà) ma, promuovendo le false identità tribali, essa nega la soggettività dei ciascuni. Confondere le identità di ciascuno in una sola comune, che è quella umana di tutti.
La questione è se siamo capaci, oltre che di denunciare la sofferenza, di progettare e dunque di lavorare per la felicità dei soggetti e delle comunità. La felicità è possibile?
Nella globalizzazione neocapitalistica in cui stiamo affogando è necessario produrre località, intesa non nel senso vernacolare tanto caro alle leghe e ai sovranismi di ogni risma, ma come riappropriazione della vita sociale e delle proprie esistenze. Tra un locale identitario e paranoico e una globalizzazione anonima e mercificata occorre trovare lo spazio dell’oikos e l’economia del dono, intesa come il debito che ognuno di noi ha nei confronti degli altri e della società. Ecco la common decency (the free, equal and decent society) di cui parla Orwell, e che oggi si può intendere anche come la capacità degli esseri umani di vincolarsi reciprocamente uscendo dalla chiusura autistica del puro consumo o della propria fragilità. Averlo dimenticato è stato il grande errore della sinistra di governo che da almeno trent’anni non riesce più a trovare le parole della sua vocazione originaria.
Siamo in tempi di assedio e dobbiamo ricordarci che la violenza generata dalla isteria identitaria (prima gli italiani) così come è accaduta nel passato può accadere nel futuro, e non per un terribile ma imprevedibile concorso di circostanze, ma per una progressiva e sistematica costruzione di pregiudizi, di falsità storiche, di stigmatizzazioni, di promozione della paura, di uso ripetuto e sistematico della violenza verso una o più minoranze, una violenza che, al principio, è soloverbale.
Siamo in tempi di recessione non solo economica ma dei diritti, della giustizia, della tolleranza, della civiltà, della politica e dei suoi linguaggi. Sappiamo che individui e comunità di fronte a ogni fenomeno recessivo rispondono con strategie difensive, rispondono al sentimento di assedio con muri, chiusure, rafforzamenti identitari, identificazioni di colpevoli facilmente identificabili: «Chi ci comanda in alto (i politici, i tecnici, gli intellettuali) e chi attenta alle nostre identità rassicuranti in basso (i diversi)». La ferocia del linguaggio politico trova allora i suoi obiettivi: le istituzioni della politica, i politici che governano, i diversi (zingari, matti, tossicodipendenti, immigrati, rifugiati) che assediano le nostre certezze, i cosiddetti valori (patria, razza, religione), le nostre certezze economiche (lavoro, risparmio, proprietà).
È giunto il tempo di salvaguardare i cammini di liberazione che tanti individui e tante comunità hanno costruito nel tempo e dunque di pensare la Speranza e l’Utopia come possibili Nord cui dirigere la navigazione. Ci vuole un certo coraggio a pensare l’impossibile come possibile, a pensare forme innovative di trasformazione della realtà; si tratta in sostanza di avere il coraggio di pensare e di educare alla complessità. Tutto è semplice e falso: abolire la povertà, aiutarli a casa loro, in carcere i drogati, castrare i pedofili, non c’è destra né sinistra, il fascismo è il contrario del comunismo, eccetera.
Ma anche, al tempo stesso, si tratta di dire NO. Tuttavia dire no non significa soltanto combattere populismo, xenofobia e derive securitarie, ma anche combattere dentro noi stessi la tentazione al pessimismo passivo che ci fa rinunciare all’indispensabile ottimismo militante. Si tratta di fare della Speranza un progetto di lavoro politico per potere rinnovare sia gli strumenti di comprensione della realtà sia quelli di azione nella realtà.
È necessario tuttavia re-imparare a essere minoranza e, in questo momento storico, sapere produrre un eccesso di affettività individuale e di solidarietà collettiva. È da questo eccesso che è necessario trasformare malessere e indignazione in energia politica capace di generare lavoro culturale meticoloso, capillare e intenso fra coloro che non contano con l’obiettivo di generare un nuovo e diffuso consenso verso una fraternità ospitale che cessa di essere esclusivamente virtù individuale per divenire sentimento civile, condiviso e collettivo: cemento di spiritualità trasversali laiche e religiose.Valeva per i matti da slegare, valeva per i ragazzi di Barbiana e vale sempre per gli scarti di ogni genere che la società confina ai margini, ricordandosene solo per qualche episodio di cronaca nera: adolescenti demotivati perché senza futuro, anziani soli e abbandonati, giovani madri senza casa e lavoro, carcerati, tossicodipendenti… E in generale tutti i soggetti «costantemente al margine dei diritti, dell’accesso ai servizi, dell’accesso alle opportunità, dell’accesso ai beni e agli scambi, dell’accesso alla speranza di esserci per il futuro». Oggi soprattutto vale per i migranti, che non sono veicoli di malattie e di miseria ma portatori di culture diverse, di una ricchezza umana di cui usufruire, di una sofferenza da condividere empaticamente. In ogni caso non da affrontare con «ricette di gestione aziendale, come se il pianeta fosse un’azienda un po’ più grande.»
La cattiveria è semplice mentre la bontà è difficile. Ecco perché la cattiveria viaggia veloce e giunge al cuore delle persone. «Dobbiamo essere crudeli, dobbiamo esserlo con la coscienza pulita, dobbiamo distruggere in maniera tecnico-scientifica» scriveva Hitler nel suo Mein Kampf. La bontà si ferma a livello individuale ma fatica a divenire processo collettivo: abbiamo tanti esempi di cattiveria divenuta azione collettiva ma fatichiamo a trovare esempi di bontà divenuta azione collettiva.
È urgente liberare energia politica capace di alimentare e governare nuovi conflitti politici e sociali. Dobbiamo trovare le strade per tornare a grandi conflitti in nome della bontà. Come diceva un antico maestro, Rabbi Tarfon: «Non spetta a te compiere l’opera, ma non ti è dato sottrartene.»




